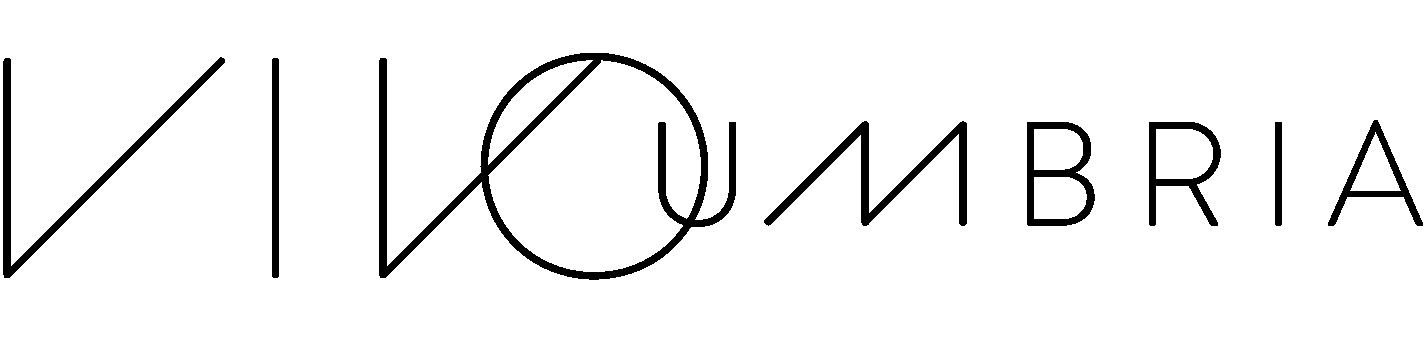PERUGIA – Nell’ambito di Umbrialibri, si svolgerà domenica 26 ottobre (ore 16) nella Sala Falcone e Borsellino del Palazzo della Provincia, la presentazione del romanzo di Ugo Coppari “Guida all’installazione di un futuro me” (Quodlibet editrice). All’incontro con l’autore parteciperanno Fabrizio Scrivano dell’Università di Perugia e Francesca Chiappalone della Libreria Mannaggia, sarà presente il gruppo di lettura della libreria.
Romanzo insolito che riguarda un futuro già in atto. In cosa consiste la nostra vita? Siamo traducibili in dati? In quest’epoca ossessionata dal mito dell’immortalità digitale, l’autore tenta di ricostruire il senso della propria esistenza attraverso la registrazione maniacale in forma di lista di tutte le esperienze vissute, che poi diventano un resoconto dal forte lirismo. Guida utile per quell’eventuale programmatore futuro che dovrà installare il gemello digitale di una persona, trasformandolo in anima digitale con cui poter dialogare dopo la morte fisica. È anche un dubbio sui limiti dell’intelligenza artificiale e sul valore della narrativa, capace di dire ancora qualcosa in questa sfuggente, sparpagliata e oscura contemporaneità.
E’ lo stesso autore che fornisce maggiori ragguagli sul suo lavoro: Il romanzo “Manuale di installazione di un futuro me” – scrive Coppari – risponde a queste domande: possiamo tradurre la nostra vita in dati? Cosa rende significativa la nostra vita? Il contesto è questo: negli anni ‘70, in California, nasce quel movimento chiamato transumanista che mira a rendere la vita eterna, attraverso la crioconservazione. Ci si fa congelare nella speranza di poter risorgere in un periodo storico o in un altro pianeta più favorevole. Nel tempo, però, ci si è chiesti come conservare e trasporre tutti i ricordi, l’impianto neuronale, in poche parole, la mente del soggetto da ibernare (attualmente ci sono 200 persone, negli Stati Uniti, in attesa di scongelamento). Così si comincerà a parlare di mind uploading. Passano gli anni e questi argomenti vengono usati per affrontare un’altra questione: possiamo estendere la nostra presenza nel mondo dei vivi anche dopo la morte fisica e celebrale? Secondo molti la risposta starebbe nel creare un nostro “digital twin”, un gemello digitale, che possa dialogare con chi gli è sopravvissuto (tra i nomi più suggestivi dati a queste entità digitali c’è quella dei thanabot). E per farlo basta sottoporre ai programmi di intelligenza artificiale già elaborati nostri file testuali, audio e video da processare per permettere al nostro avatar di assumere le nostre sembianze, essere il più aderente possibile al nostro sé quando era ancora in vita. Detto questo, ecco che nel mio romanzo parto (nel primo capitolo: “La vita come quantità”) con il raccontare la mia vita al programmatore che dovrà caricare la mia identità, la mia mente (mind uploading): e lo farò attraverso il resoconto in termini quantitativi di tutte le esperienze fatte nel corso della mia vita (essendo un amante delle liste, mi è venuto facile). In un secondo momento (nel secondo capitolo: “La vita come qualità”), accentuando il lirismo e mettendo da parte le liste, dimostrerò invece che questi dati non possono riportare il significato di un’esistenza, sottolineando quindi come la letteratura possa invece dirci molto di più su quello che ci contraddistingue. Il romanzo si intitola provocatoriamente “manuale” perché è pensato come testo di installazione indirizzato – questo il mio lettore empirico – al programmatore che si dovrà occupare della mia sopravvivenza digitale. Perché tutto questo. Ho sempre apprezzato quei testi letterari che hanno saputo essere figli del proprio tempo. Cervantes ridicolizza la letteratura cavalleresca inserendo la figura di un folle, Don Chisciotte, che sconquassa tutta la linearità logica e narrativa del genere allora tanto in voga. Supera e deride il Medioevo dando così vita al romanzo moderno. Pirandello traduce tutte le scoperte di inizio ‘900 in fare letterario: l’io si disgrega in tante identità che convivono tra loro e i suoi testi, sia narrativi che teatrali (con l’abbattimento della cosiddetta quarta parete) ne sono influenzati. Altri esempi contemporanei: “Lincoln in the Bardo”, dove dei fantasmi sospesi tra la vita e la morte (nel Bardo, appunto) dialogano tra loro come stessero in una chat (l’idea, dice l’autore Sanders, gli è venuta guardando sua figlia chattare su Messenger); o “Exit West” (di Mohsin Hamid), dove i migranti possono migrare da un Paese all’altro entrando e uscendo dagli armadi, come fossero specchi magici. Insomma, se un romanzo può (o deve) far parlare il proprio tempo, cosa c’è di meglio di una storia che ha a che fare con la quantificazione del sé (siamo pieni di app che ci misurano il sonno, la prestazione sportiva, le spese, ecc – una tendenza che ha preso il nome di “quantified self”), con la pretesa di digitalizzare il mondo e – ancora più importante – con lo spodestamento di Dio dal centro della scena a favore di un io potenzialmente eterno? E infine: non esiste già, in fondo, quel mezzo che ci permette di parlare con le persone già morte? Semplice, comodo, profondo, si chiama libro. E questo manuale ne è la dimostrazione”.
Ugo Coppari
Ugo Coppari vive a Perugia. Fondatore della scuola Studio Pensierini, dove insegna italiano a stranieri: 1.000 studenti, di 40 diverse nazionalità, dai quali, in tanti anni, ha mutuato il modo sbilenco di esprimersi per farne tesoro nella sua scrittura, alla ricerca della propria voce. Ha pubblicato raccolte di racconti (Nove anoressiche, 2007; Il grande rimbalzo, 2014; Terra, 2023) e romanzi brevi (Bim bum bam, 2006; Limbo mobile, 2009). Il suo Aria, pubblicato nel giugno del 2021, è stato per una settimana tra i libri in ebook più venduti in Italia.
PH Marta Passalacqua