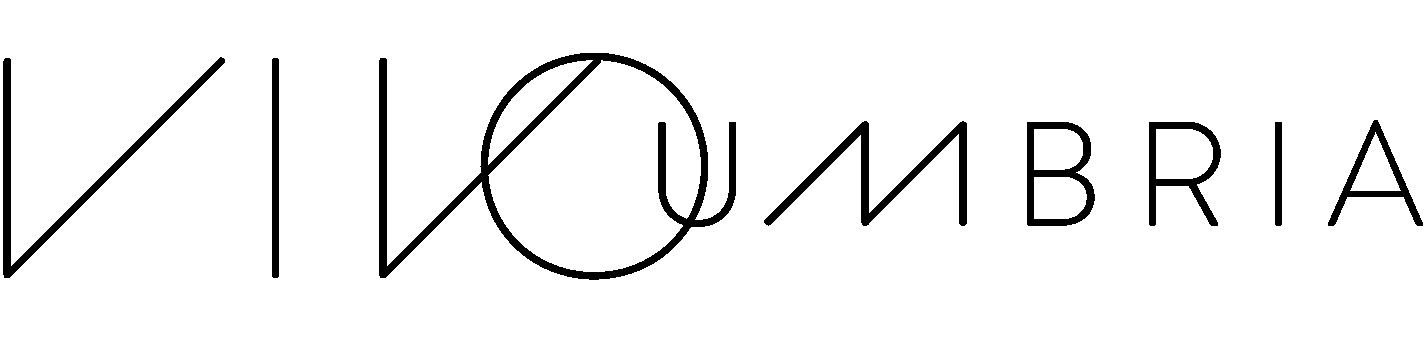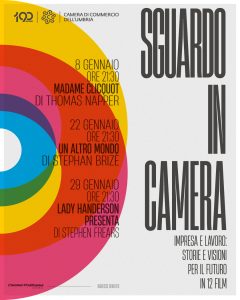CITTA’ DI CASTELLO – Continuano gli appuntamenti del Festival delle Nazioni, dopo il successo dell’inaugurazione.
Il 30 agosto (ore 18.30) Les Coquelicots Trio, formazione specializzata nel repertorio francese, nel Monastero Santissimo Crocifisso e di Santa Maria di Citerna darà vita alla Promenade Dans le Jardin de l’Ame, (realizzato in collaborazione con la Fondazione “Luigi Bon”) viaggio tra le note di Bonis, Faurè, Du Parc, Debussy, Satie, Poulenc, Ravel, Massenet.
Passaggio di testimone a RisuonArte: Carte blanche a Ensemble Suono Giallo titolo del progetto affidato all’omonimo Ensemble umbro, ormai affermato sulla scena internazionale, soprattutto come raffinato interprete della musica contemporanea. I musicisti di Suono Giallo – il 30 (ore 16 Auditorium San Giovanni Decollato, ore 17.00 Fondazione Burri Ex-Essicatoi del Tabacco) e 31 agosto (ore 16 Museo Diocesano, ore 17 Pinacoteca Comunale) – accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso le musiche di Ravel, Berio (di cui quest’anno si ricordano i cento anni dalla nascita) Scodanibbio, Sciarrino e Aperghis. In maniera speculare, contemporaneamente, lo spettatore sarà accolto da guide esperte per essere condotto attraverso le splendide sale degli Ex Seccatoi del tabacco sede della rinomata Collezione Burri, della Pinacoteca Comunale, del Museo Diocesano e dell’Auditorium San Giovanni Decollato che racchiude al suo interno due dipinti attribuiti alla scuola di Luca Signorelli.
E tra i grandi interpreti per il palcoscenico del Festival delle Nazioni, Richard Galliano, uno dei massimi esponenti della musica jazz, presenterà il 31 agosto (ore 21.00) nella Chiesa di San Domenico di Città di Castello, un programma dedicato alla Parigi del dopoguerra, e festeggerà proprio a Città di Castello i suoi cinquanta anni di luminosa carriera.
I programmi dei concerti
Il brano Valses nobles et sentimentales di Maurice Ravel fu eseguito per la prima volta nel 1911 in un concerto anonimo organizzato dalla Société Musicale Indépendante, dove i nomi degli autori non venivano svelati al pubblico, che doveva indovinarli. L’opera fu accolta con perplessità e critiche, a causa delle sue dissonanze che furono scambiate per errori. Solo pochi riuscirono a riconoscere lo stile di Ravel. L’anno seguente, il compositore ne realizzò una versione orchestrale per il balletto Adélaïde ou le Langage des fleurs. Ravel dichiarò di ispirarsi esplicitamente a Schubert, ma in realtà il suo stile si avvicina di più a Chabrier: il ciclo si distingue per la chiarezza della scrittura, la raffinatezza armonica e l’intento di superare il virtuosismo cupo di opere precedenti come Gaspard de la nuit. I valzer alternano atmosfere diverse, ma condividono una costruzione formale solida e una continua tensione tra melodia e armonia. L’epigrafe in apertura – tratta da Henri de Régnier – allude, in modo ironico e malinconico, al piacere effimero dell’arte.
Passando a Georges Aperghis, Le Corps à corps (1978) è un’opera che unisce musica e teatro, scritta per il percussionista Jean-Pierre Drouet. È un brano singolare, in cui il musicista interpreta una narrazione surreale e drammatica legata al mondo delle corse automobilistiche. L’opera non si limita al suono, ma coinvolge la voce, i gesti e il corpo dell’esecutore, creando un vero e proprio teatro musicale. Aperghis esplora il confine tra parola e suono, e tra azione e narrazione, con un linguaggio frammentato e denso di tensione, in cui la componente scenica è tanto importante quanto quella musicale.
Infine, Salvatore Sciarrino ha dedicato un ampio corpus compositivo al flauto, reinventandone la voce in modo profondo e radicale. Nei suoi primi lavori, il flauto è associato a suoni evanescenti, soffi, armonici e tremolii, mentre in quelli della seconda fase (anni ’90-2000), lo strumento assume una fisicità maggiore e una pulsazione più marcata, come si nota in Immagine fenicia. Negli anni più recenti, Sciarrino ha scelto di non introdurre nuove tecniche, ma di offrire nuove prospettive poetiche, spesso ispirate a paesaggi urbani e ricordi di viaggio. L’opera Ai futuri fauni, nuova versione di Fogli per giovani fauni, è un esempio emblematico di questo approccio: articolata in tre movimenti, intreccia frammenti melodici ispirati alla canzone jazz Cherokee e a Wagner, soffia sospesi e trame evanescenti, in un linguaggio fatto di citazioni distorte, silenzi e delicatissimi colori sonori.
Le Sequenze di Luciano Berio, composte tra il 1958 e il 2002, rappresentano un corpus fondamentale della musica contemporanea. Sono frutto di un’approfondita esplorazione timbrica ed espressiva dei singoli strumenti e riflettono un intenso dialogo tra il compositore e gli interpreti. Berio non intende forzare gli strumenti, ma piuttosto valorizzarne la natura, pur spingendoli al limite, con una scrittura ricca di sfide tecniche, fisiche e teatrali. Ogni Sequenza nasce con un’identità propria, ma condividono tutte un’attenzione particolare per la struttura armonica, per la polifonia implicita e per la continua trasformazione del materiale musicale.
Due esempi particolarmente interessanti sono la Sequenza VIIb per sassofono soprano e la Sequenza IXb per sassofono contralto, entrambe nate come trascrizioni di versioni precedenti (rispettivamente per oboe e per clarinetto). La Sequenza VIIb, sviluppata con Claude Delangle, ruota attorno a un “si” bordone fisso che accompagna tutta l’esecuzione e funge da perno armonico e metafisico. Il discorso musicale si sviluppa come una trasformazione continua, tra effetti estesi, multifonici, growl e gesti virtuosistici, in un clima sonoro che oscilla tra tensione e rarefazione.
Più cantabile e meditativa è la Sequenza IXb, che mantiene l’impronta melodica dell’originale per clarinetto. Costruita su due campi armonici, sviluppa una linea sonora fluida e fluttuante, con tecniche avanzate ma sempre piegate a un’espressività lirica e mutevole. La melodia sembra smarrirsi e riemergere, tra echi, sospensioni e suoni evanescenti, in un gioco continuo di trasformazione e ritorno.
Accanto a Berio, il contrabbassista e compositore Stefano Scodanibbio ha dato un contributo determinante alla valorizzazione del contrabbasso nella musica contemporanea. La sua scrittura, sempre molto precisa e lontana dall’improvvisazione, parte dalla fisicità dello strumento e ne esplora l’intero spettro sonoro: armonici, pizzicati, glissandi, percussioni sul corpo del contrabbasso, suoni acutissimi e gravi che convivono in una sorta di contrappunto timbrico.
In Alisei (1986), Scodanibbio fa “cantare” il contrabbasso con una voce unica, fatta di armonici tremolanti, suoni sospesi e movimenti lenti e poetici. Invece, Geografia amorosa (1994) è una sorta di viaggio timbrico e ritmico, con uso di live electronics e tecniche non convenzionali: lo strumento diventa un vero e proprio laboratorio acustico, capace di evocare culture diverse e universi sonori alternativi, in un crescendo di energia che si dissolve infine in echi percussivi quasi impercettibili.
“Promenade dans le jardin de l’âme” (“Passeggiata nel giardino dell’anima”), interamente dedicato alla mélodie francese, è un genere musicale raffinato e intimo che si sviluppò tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, principalmente nei salotti parigini.
Mentre il mondo musicale esterno era agitato da correnti come wagnerismo, verismo ed espressionismo, la mélodie offriva uno spazio più raccolto, delicato e poetico: un vero e proprio “giardino dell’anima”, dove emozioni e sensazioni venivano esplorate con finezza e sensibilità.
Il concerto propone un percorso musicale variegato, come un giardino senza una geometria precisa, ma pieno di sentieri inaspettati e suggestioni. Si parte con Mel Bonis, una compositrice poco conosciuta, che per nascondere la sua identità femminile firmava le sue opere con uno pseudonimo. Le sue composizioni sono brevi, delicate e profondamente poetiche, come “Romances sans paroles” e “Gai printemps”. Segue Gabriel Fauré, una delle figure centrali della mélodie francese, di cui vengono eseguiti brani emblematici come “Au bord de l’eau”, “Elégie”, “Sicilienne” e “Après un rêve”, nei quali si fondono eleganza, malinconia e raffinatezza armonica. Si passa poi a Henri Duparc, autore tormentato che smise presto di comporre ma ci ha lasciato capolavori come “Invitation au voyage” e “Chanson triste”, fortemente influenzati dall’atmosfera wagneriana, pur sempre filtrata dal gusto francese. Viene poi presentato Jules Massenet, celebre soprattutto per l’opera lirica, ma anche autore di circa 400 mélodies. Due esempi proposti sono “Elégie” e “On dit”, dove si avverte una tenera malinconia e una cantabilità fluida. La figura di Claude Debussy segna un cambiamento radicale: le sue “Romances” mostrano un linguaggio musicale nuovo, ispirato ma non riducibile al simbolismo o all’impressionismo. In questi brani il pianoforte ha un ruolo centrale, evocando stati d’animo impalpabili e poetici. Dopo un ritorno alla Bonis, si giunge a Erik Satie, spirito ironico e provocatorio, che con le sue mélodies del 1916 (“La statue de bronze”, “Daphnénéo”, “Le chapelier”) rompe con la tradizione lirica e introduce elementi di umorismo surreale. Chiude il concerto il suo celebre valzer “Je te veux”, sensuale e nostalgico, emblema della Belle Époque.
Nel finale, prima della conclusione, si incontrano altri autori: Francis Poulenc, con “Montparnasse” e “Les chemins de l’amour”, brani pieni di eleganza e malinconia, e Maurice Ravel, con le sue “Cinq mélodies populaires grecques”, adattamenti di melodie tradizionali greche, trattate con rispetto ma arricchite dalla sua inconfondibile tavolozza armonica.
Il concerto si conclude con un riepilogo delle mélodies di Fauré, Massenet e Satie, offrendo così un affascinante panorama di questo repertorio raffinato, intimo e spesso trascurato, ma ricco di poesia e profondità emotiva.
Richard Galliano è un musicista che ha saputo riportare in auge la fisarmonica, strumento a lungo relegato a un ruolo secondario e considerato ormai superato, restituendole dignità artistica e rilevanza culturale. La sua storia personale e musicale affonda le radici nella tradizione popolare francese del bal musette, i balli delle classi popolari che animavano le guinguettes parigine tra Ottocento e Novecento. Ambienti semplici e conviviali, lontani dall’élite borghese, ma ricchi di vita e musicalità. La fisarmonica, che con il tempo prese il posto della musette (una sorta di cornamusa), divenne lo strumento simbolo di questo mondo.
Galliano è cresciuto immerso in quella cultura grazie al padre, anch’egli fisarmonicista, e ha vissuto da vicino il declino del genere, messo da parte da una gioventù sempre più attratta dal pop anglosassone degli anni Sessanta. Trasferitosi a Parigi nei primi anni ’70, iniziò la carriera come arrangiatore e direttore d’orchestra per Claude Nougaro, entrando così in contatto sia con il mondo della chanson francese che con il jazz, sviluppando una sensibilità musicale ampia e versatile.
Il punto di svolta arriva con l’incontro con Astor Piazzolla, che lo spinge a riscoprire le proprie radici musicali e a farne il punto di partenza per un nuovo linguaggio. È così che nasce la new musette, una sintesi raffinata e personale di stili diversi: le melodie dei valzer parigini, la forza espressiva del tango argentino, l’eleganza della chanson, le libertà del jazz e le raffinatezze armoniche della musica classica del Novecento. Galliano fonde tutto questo in uno stile riconoscibile, colto ma accessibile, ricco di lirismo e improvvisazione, che ridefinisce il ruolo della fisarmonica.
Il primo disco che segna questa rinascita è Spleen (1985), seguito poi da New Musette (1991), una sorta di manifesto artistico registrato con importanti jazzisti europei. In questi lavori si delineano già alcuni dei suoi brani più celebri, come Ballade pour Marion, La valse à Margaux o Tea for Toots, veri e propri classici contemporanei.
Galliano si è sempre mosso con naturalezza tra generi e collaborazioni, senza mai snaturare la propria identità: ha suonato con figure del jazz internazionale come Chet Baker o Ron Carter, ma anche con artisti italiani come Enrico Rava e Gianni Coscia, contribuendo a far scoprire a molti nuovi repertori. Il sodalizio con Michel Portal, in particolare, ha dato vita al sorprendente Blow Up (1997), un disco vivace e sfaccettato che ha avuto successo anche fuori dai circuiti specialistici.
Nel 2016 pubblica New Jazz Musette, che riassume e rinnova il suo percorso musicale: una raccolta di brani reinterpretati con nuovi arrangiamenti e nuovi compagni di viaggio, capace di emozionare senza cadere nella nostalgia, ma anzi aprendosi a nuovi orizzonti, con accenti swing, blues, tango e manouche. L’unico inedito del disco, Nice Blues, è una toccante dedica alla città di Nizza colpita da un attentato, testimonianza della sensibilità umana oltre che musicale di Galliano.
La sua abilità non sta solo nella tecnica sopraffina, ma soprattutto nella capacità di adattarsi con creatività ai contesti più diversi, mantenendo sempre una voce personale e coerente. Non ha mai cercato di “fare il jazzista” in senso stretto, ma ha saputo dialogare con quel mondo usando un linguaggio autentico e privo di forzature.
Il french touch di Galliano – fondato su una concezione ritmica flessibile, di matrice africana, e su armonie ricercate – ha così contribuito a liberare la fisarmonica dalla sua immagine antiquata. Le sue performance dal vivo restano esperienze uniche: il repertorio è ampio, la sensibilità interpretativa altissima, e l’improvvisazione sempre aperta alle sorprese della serata. In lui convivono passato e futuro, tradizione popolare e linguaggi colti, nostalgia e invenzione: un raro esempio di artista capace di reinventare il proprio strumento senza tradirne l’anima.