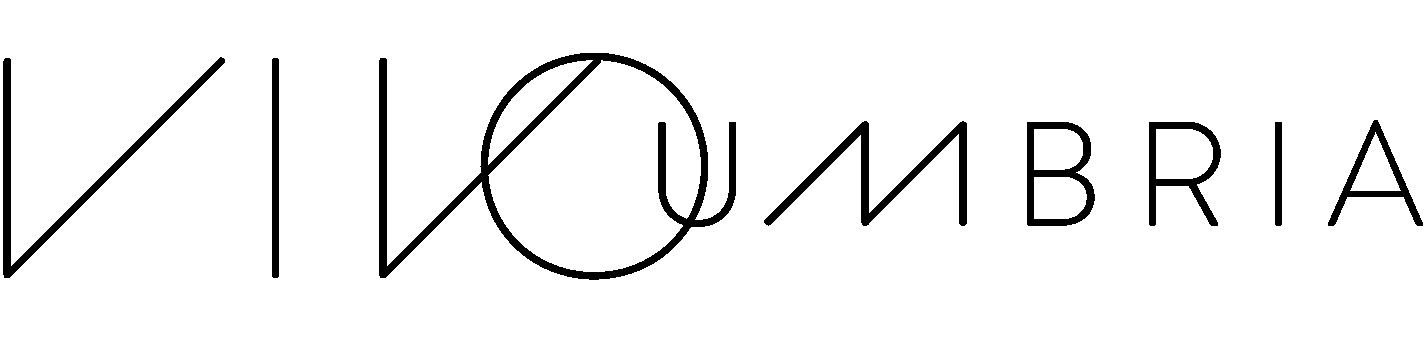PERUGIA – Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, la mostra Papaveri rossi offre un’occasione preziosa per riscoprire un Mario Giacomelli diverso, inatteso, capace di spingersi oltre i confini della fotografia in bianco e nero che lo ha reso celebre. Qui, tra opere note e immagini inedite, il fotografo marchigiano si misura con il colore, trasformandolo in strumento poetico e concettuale, in un linguaggio vicino alla pittura e all’astrazione.
La mostra alla Gnu nell’ambito del ciclo di Camera Oscura curato da Marina Bon Valsassina, rimarrà aperta al pubblico da oggi al 6 aprile 2026. Come ha specificato Costantino D’Orazio e il curatore Alessandro Sarteani, un Giacomelli che abbandona la sua “tavolozza” di bianco e nero per abbracciare il colore, ma un colore rielaborato in postproduzione che attraverso lo sguardo sull’altopiano di Castelluccio, è capace di raccontare qualcosa in più del nostro territorio, così come anche gli altri grandi maestri del ciclo Camera Oscura, sono stati capaci di fare.
Ma per comprendere fino in fondo la svolta cromatica di Giacomelli, è utile ricordare il legame profondo tra il fotografo e Alberto Burri, due artisti che, pur operando in ambiti diversi, hanno condiviso una stessa tensione: quella verso un’arte essenziale, materica e visionaria, capace di nascere dal reale per trasfigurarlo.
Giacomelli, nato a Senigallia nel 1925, non fu mai un semplice fotografo “di realtà”. Fin dagli esordi, il suo obiettivo ha cercato un oltre, un punto di equilibrio tra documento e invenzione. Le sue serie più celebri – da Scanno a Io non ho mani che mi accarezzino il volto – mostrano un mondo contadino, religioso, umano, ma filtrato attraverso una grammatica visiva radicale, fatta di contrasti estremi, grafismi, deformazioni.
In questo senso, la sua fotografia è già pittura e incisione, un processo di sottrazione e costruzione della forma. È proprio qui che si innesta la vicinanza con Burri, che nello stesso periodo lavorava su combustioni, sacchi e cretti, trasformando la materia povera in linguaggio estetico. Entrambi cercavano di estrarre l’astrazione dal reale, non per negarlo, ma per rivelarne una verità più profonda, più interiore.
La mostra Papaveri rossi rivela un Giacomelli che esplora il colore come territorio emotivo e mentale. Le fotografie esposte, molte delle quali inedite, mostrano paesaggi e nature reinterpretate attraverso una sensibilità cromatica che ricorda la pittura informale e l’espressionismo astratto.
Il rosso dei papaveri, che dà il titolo alla mostra, diventa metafora di vitalità e di ferita, di bellezza e di morte. È un colore che vibra come materia, come superficie bruciata — non a caso un richiamo implicito alle combustioni di Burri. Nelle mani di Giacomelli, il colore non descrive ma evoca, non imita ma suggerisce, trasformando la fotografia in gesto pittorico.
Giacomelli e Burri si incontrano idealmente in questa concezione astratta dell’arte, intesa non come negazione della realtà ma come ricerca dell’essenza. Se Burri scava nella materia fino a farla esplodere in forma, Giacomelli scava nella luce fino a farla diventare segno. Entrambi condividono una poetica della trasformazione, del “fare” come atto esistenziale e spirituale. Alcune immagini di Giacomelli provengono dalla concessione della Fondazione Burri e sono il frutto degli omaggi che il fotografo riservava proprio all’amico Burri.
Papaveri rossi restituisce al pubblico un Giacomelli sorprendente, che rinnova il linguaggio fotografico e ne espande i confini. Il dialogo implicito con Burri, l’amico e il maestro di materia e silenzio, emerge come chiave interpretativa profonda: due artisti diversi, uniti dalla stessa urgenza di trasformare la realtà in visione.
In un tempo in cui la fotografia tende spesso a documentare, Giacomelli ci ricorda che essa può anche inventare, sentire, pensare. Come l’arte di Burri, anche la sua è una forma di resistenza poetica: un modo per trovare, nei papaveri rossi della vita, l’eco di un’emozione che non smette di bruciare.