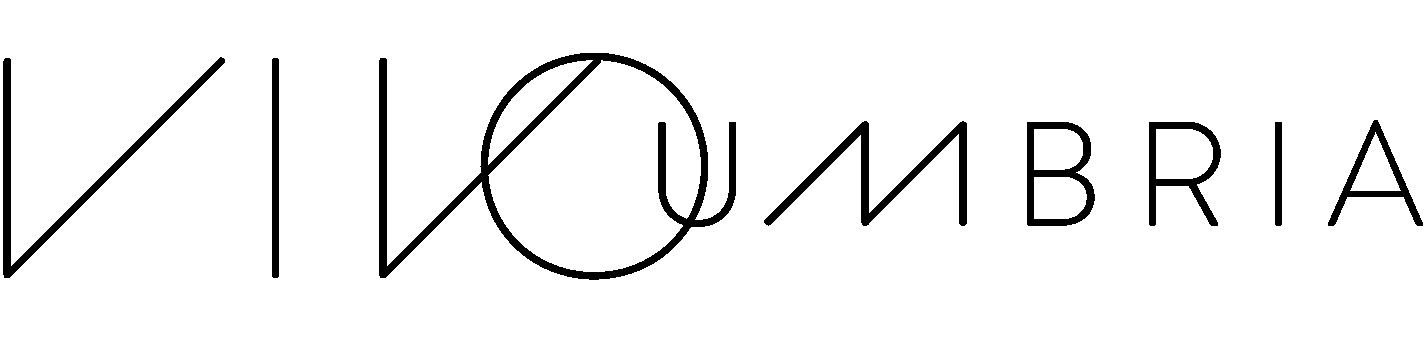PAPIGNO – Un tempo era il borgo delle viti, degli ulivi e dei frutteti dove, a pochi passi dalla Cascata delle Marmore, maturavano i “persichi”, le rinomate pesche di Papigno dal colore giallo oro e dal sapore ineguagliabile. La ricchezza delle acque della Valnerina rendeva fertili i terreni e alimentava i piccoli opifici. I colori e i sapori di quell’incantevole promontorio pullulante di una vita scandita dal ritmo delle stagioni riempivano i taccuini di viaggio degli aristocratici visitatori del Grand Tour. E se Jean Baptiste Camille Corot che vi soggiornò nel 1826 e nel 1828 realizzò en plein air alcuni dipinti e disegni del borgo rendendolo immortale, Carolina di Brunswick – principessa del Galles che sarà incoronata regina di Gran Bretagna nel 1820 in quanto legittima moglie di re Giorgio IV– fu ospite a Villa Graziani con il suo maggiordomo. O forse amante, come documenta Christian Armadori nel blog Londra in italiano. Sontuoso edificio del XVI secolo eretto sulla riva destra del fiume, la villa di proprietà del Conte Graziani – gonfaloniere di Terni dal 1823 al 1828, agricoltore innovativo, raffinato anfitrione e cuoco sopraffino – vantava una vasta proprietà agricola, un magnifico giardino e splendidi agrumeti, oltre a una pregevole cappella privata. La principessa, a quanto raccontano le cronache del tempo, lasciò Papigno con riluttanza, non senza essersi prima assicurata la fornitura di pesche in patria.
Il progresso
Alla fine dell’Ottocento, tuttavia, quel che appariva come un piccolo Eden sembrò idoneo per una colossale impresa industriale. A Papigno, il monte Sant’Angelo, ricco di giacimenti di calcare, poteva offrire la materia prima. Di acqua per mandare avanti le macchine ce n’era a iosa. La forza lavoro si sarebbe trovata sul posto. Altri operai sarebbero arrivati. Nel 1901, lo stabilimento elettrochimico della SICCAG – Società Italiana per il Carburo di Calcio Acetilene e Altri Gas invade “la valle incantata” con il suo corollario di edifici in cemento armato e laterizi di grandi dimensioni, condotte forzate e teleferica a scavalcare la strada e il corso del Nera per unire le due parti di un complesso che, negli anni Sessanta, arriverà a occupare una superficie complessiva di 105.450 mq. Destinato alla produzione di carburo di calcio, sostanza chimica impiegata nel campo dell’illuminazione mediante gas acetilene, a questa si aggiunge nel 1907 la produzione della calciocianamide, un fertilizzante utilizzato in agricoltura derivato dal carburo.
Nel 1911, lo stabilimento viene dotato di una grande centrale idroelettrica che sfrutta le acque derivate dal Velino per produrre energia elettrica. Il tram che dal 1909 raggiunge anche Ferentillo collega tra loro e con la stazione di Terni quasi tutti gli stabilimenti della Valnerina, trasportando merci e persone. Il “progresso” conquista definitivamente Papigno. Peccato gli odori nauseabondi, i rumori assordanti, l’indelebile polvere grigia sui tetti delle case, sulle radure, sugli alberi, dentro le narici, nei polmoni. Peccato il monte sventrato, le colture distrutte, le persone ammalate. Peccato la cappella gentilizia di Villa Graziani utilizzata come cabina elettrica. Peccato che, inspiegabilmente, “le pesche se so’ seccate”.
Per settant’anni gli abitanti di Papigno saranno Gli impolverati: “uomini e donne che per scelte strategiche nazionali furono costretti ad infrangere il patto con la terra, sopraffatti da Commendatori, Cavalieri, Ingegneri che promettevano lavoro e ricchezza” – come racconta Maria Cristina Garofalo nella sua ben documentata Cronaca di un ecocidio stampato nel 2016 dalla Tipografia Visconti, e come conferma Sandro Porrazzini ne La carburo di Papigno pubblicato da Thyrus nel 2023, libro che raccoglie le immagini dello stabilimento e le testimonianze di chi ci ha lavorato, perdendoci la salute.
Nel 1922, la Società del Carburo viene assorbita dalla Società degli Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni che, sotto il nome di Società Terni per l’Industria e l’Elettricità, nel giro di una decina d’anni assumerà il controllo di numerose industrie del territorio. Anche la produzione chimica, sviluppata a Collestatte fino al 1929, si concentrerà a Papigno. La guerra e le successive crisi del mercato ridimensioneranno le produzioni del carburo e della cianamide. Nel 1962, l’energia elettrica viene nazionalizzata, aprendo così la crisi dell’elettrochimico. L’industria chimica passerà di acquisizione in acquisizione, fino alla chiusura dello stabilimento nel 1973. Rimarrà in funzione fino alla metà degli anni Ottanta la produzione di ossigeno a fini industriali ad uso della Terni.
Il degrado e l’archeologia industriale
Ritenuto oggi uno dei più grandi siti di archeologia industriale dell’Italia centrale, lo stabilimento fu acquisito dal Comune di Terni tra il 1997 e il 2003 e parzialmente recuperato per farne un centro di produzione cinematografica. Negli Studios di Papigno nel 1997 è stato girato La vita è bella di Roberto Benigni, vincitore di tre premi Oscar; poi il meno fortunato Pinocchio e altre produzioni internazionali; poi, niente più. Tra i motivi della dismissione di Cinecittà Papigno, anche il fatto che nel 2001 l’area fosse stata individuata come SIN – sito di interesse nazionale per la bonifica, con Maratta, Prisciano e Nera Montoro.
Svanito il sogno di celluloide di una Hollywood sul Nera e in attesa di veder finalmente risanato un territorio fortemente inquinato, anche il “gioiello di archeologia industriale”, dopo anni di abbandono, si sta sgretolando. Non ne sarebbe lieto il “poeta-ingegnere” Gino Papuli, scomparso nel 2008, tra i primi studiosi a interessarsi del destino delle macchine e degli impianti industriali in dismissione.
Tecnologo umanista, primo docente universitario a insegnare archeologia industriale, divenuta anche grazie a lui una vera e propria disciplina scientifica, Papuli fu il fautore del salvataggio della Pressa da 12.000 tonnellate dell’Acciaieria, assurta nel 1999 a monumento industriale di fronte alla stazione ferroviaria di Terni. Una sorte meno gloriosa è toccata alla vecchia Telfer di Papigno, la teleferica in struttura di acciaio reticolare che scavalcava il fiume e la strada Valnerina, tagliata e smontata nel 2018 perché ritenuta pericolante. Inascoltati gli appelli perché fosse almeno musealizzata, i monconi sono ancora oggi aggrappati ai lati dei due edifici che si fronteggiano sui due versanti della strada. La struttura del ponte giace a terra, poco più avanti. A vegliarla, lo scheletro annerito di un edificio di cemento all’interno del quale, tra vecchi macchinari divelti, evidenti sottrazioni di rame e muri pericolanti, per qualcuno si anniderebbero anche materiali pericolosi come “amianto, piombo, eternit, polveri sottili, lana di vetro. Non sembrano passarsela meglio l’antica centrale idroelettrica e i capannoni visitati dagli esploratori di Lost Structures – canale YouTube dedicato all’archeologia industriale e alle ex installazioni militari – che nel 2021 nelle strutture dello stabilimento di Papigno scoprivano “macchinari dell’epoca ancora in buone condizioni di conservazione in ambienti molto degradati, ed in certi casi pericolosi per la possibile caduta di materiali dal tetto, in certi punti crollato e pericolante. Anche il pavimento presenta molte insidie, come buche e aperture dalle quali si può facilmente cadere nel vuoto”.
[Best_Wordpress_Gallery id=”2622″ gal_title=”papigno”]
Un altro film
Sembrano, invece, caduti nel dimenticatoio i progetti avanzati nel tempo per un recupero del complesso in funzione ora di museo dell’industria, ora di museo diffuso delle tradizioni popolari, ora di parco tematico sugli sport della Valnerina. Come quello proposto dall’architetto Walter Ballarini che, da una decina d’anni, negli edifici corrosi dal tempo e dall’incuria immagina hotel per gli sportivi, negozi, ristoranti, punti vendita di prodotti tipici, palestre, percorsi di addestramento, attività indoor e nuove mobilità per raggiungere la Cascata, inseguendo a Papigno “un altro film”.
Per alcuni, si dovrebbe iniziare demolendo la struttura pericolante visibile dalla strada che conduce da Terni alla Cascata delle Marmore – “pessimo biglietto da visita per i turisti” – e concentrare le energie e le risorse per rivitalizzare il resto del complesso, al momento occupato solo in minima parte dalle associazioni sportive. Per altri, qualunque porzione andrebbe tutelata e valorizzata, al pari della piccola stazione del tram in prossimità dello stabilimento, dismessa negli anni Sessanta e recentemente ristrutturata.
E mentre le ipotesi viaggiano sul web, consola la notizia che l’associazione Papigno Pesche sia al lavoro per riportare a casa i leggendari persichi.
Lorella Giulivi