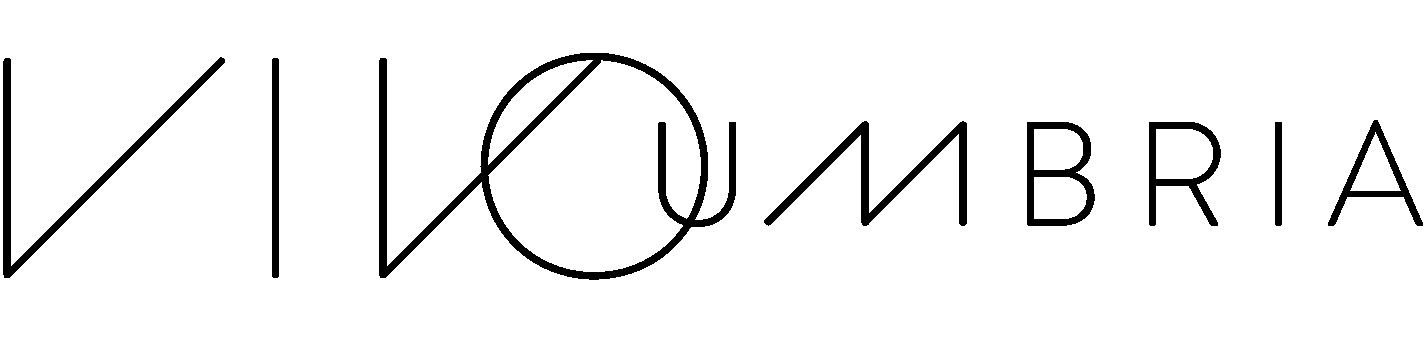PERUGIA – Vinicio Capossela ha un legame speciale con l’Umbria. Lo ha dimostrato una volta di più quando ha suonato al Festival dei Due Mondi di Spoleto lo scorso 7 luglio in un concerto magico in piazza Duomo. Qui sono stati rappresentati le pestilenze del presente e i miti e le mitologiche credenze del passato mentre sul palco c’erano Patrizia Bovi, Goffredo degli Esposti, Gabriele Russo, nucleo fondante assieme ad Adolfo Broegg, di Micrologus, che hanno conferito al medieoevo romantico delle ballate di Capossela, una sostanza musicale unica.
 Ma l’Umbria, Perugia in particolare, per questo artista è soprattutto Sergino Piazzoli che, manco a dirlo, fu l’artefice dell’incontro tra Vinicio e l’Ensemble di Assisi. Sergino per due motivi essenziali: il primo è legato al ricordo del concerto alla Sala dei Notari quando Capossella era ai più sconosciuto; il secondo per l’amicizia che ne nacque, ovvero, schietta, voluta, giocosa persino burlona. Ed è proprio da qui che inizia la nostra intervista.
Ma l’Umbria, Perugia in particolare, per questo artista è soprattutto Sergino Piazzoli che, manco a dirlo, fu l’artefice dell’incontro tra Vinicio e l’Ensemble di Assisi. Sergino per due motivi essenziali: il primo è legato al ricordo del concerto alla Sala dei Notari quando Capossella era ai più sconosciuto; il secondo per l’amicizia che ne nacque, ovvero, schietta, voluta, giocosa persino burlona. Ed è proprio da qui che inizia la nostra intervista.
Cosa di Sergino manca di più?
“Credo che noi siamo la sola forma di eternità possibile. Non siamo quello che abbiamo, ma quello che lasciamo. Viviamo nel ricordo e nella memoria di chi la conserva. Per questo la memoria è così importante. E’ il solo modo di restituire quello che abbiamo ricevuto. Persone come Sergio, che hanno dato così tanto, non solo agli amici e conoscenti, ma anche alla comunità e alla cultura, sono perdite per tutti. Sergio – prosegue Capossela – aveva già visto e cercava di combattere a suo modo quello che sta uccidendo il mestiere del promoter locale: la concentrazione e il monopolio delle grandi agenzie su tutto il mercato. Cosa che sta avvenendo in ogni campo della distribuzione. Pensiamo solo ad Amazon, per esempio. Come stanno sparendo le piccole librerie, così nel panorama della musica può venire a mancare una figura essenziale della filiera: chi ti fa scoprire qualcosa, perché ha creduto in un evento e lo ha organizzato. La musica si completa con l’ascolto. Lo spettacolo si completa con chi porta lo spettacolo nella sua piazza. E ci sono molti modi per farlo. Il modo di Sergio non trascurava mai l’umanità e il sogno che la musica può rappresentare”.
Ci saranno i Micrologus?
“Quello di Spoleto era uno degli atti unici che abbiamo messo insieme la scorsa estate per approfondire di volta in volta singoli aspetti delle ballate. L’incontro con Micrologus è avvenuto nel 2012 in occasione del concerto davanti al sagrato della basilica di Assisi. Un incontro procurato da quell’indimenticabile e straordinario promoter ed operatore culturale che è stato Sergio Piazzoli. Per me prima tappa di avvicinamento a quel mondo poetico e musicale poi sviluppato in queste ballate”.
 Stasera penultima tappa del tour “Ballate per uomini e bestie” al Morlacchi. Come sarà la versione teatrale rispetto a quella nelle piazze?
Stasera penultima tappa del tour “Ballate per uomini e bestie” al Morlacchi. Come sarà la versione teatrale rispetto a quella nelle piazze?
“Una specie di rappresentazione che unisce racconto, iconografia, teatralità e musica. Un concerto molto denso, che anche nella sua durata si propone di creare un varco tra il compatto tempo dell’Utile, un varco temporale dilatato in cui praticare la sospensione dell’incredulità. Una specie di arca in cui abbiamo messo a bordo uomini , bestie, clandestini e poveri cristi per contrastare la profetizzata e imminente sesta estinzione di massa”.
Come si fa a rendere consapevoli gli animi con i linguaggi e addirittura ingentilirli? E’ l’eterna diatriba sul ruolo del brano-canzone. Ce la possiamo fare?
“Poesia, filosofia e denunzia, come dice l’amico Federico Maria Sardelli. Mi paiono cose utili a tenere vive in noi la gentilezza d’animo e a rafforzare la consapevolezza, che è il motore primo di ogni azione. Un brano- canzone può contenere le tre cose e molte altre che però parlano all’emozione, più ancora che alla conoscenza. Gli animali per esempio, sono importanti perché tengono vivo il rapporto con l’anima. Ci ricordano che il mondo non va solo conosciuto, ma anche sentito. Alla musica, che è componente essenziale della canzone, è affidato il compito di tenere viva la nostra anima”.
 C’è una reale consapevolezza del valore delle tradizioni popolari?
C’è una reale consapevolezza del valore delle tradizioni popolari?
“La radice popolare è un po’ come l’inconscio. L’ombra culturale di cui parlava Jung. Qualcosa che è parte di noi, ma che affiora nel sogno. Noi, o almeno io, abbiamo una conoscenza mediata del mondo, mediata dagli strumenti culturali. Posso riconoscere quanto affiora in me da questo giacimento, che può parlare la lingua dei proverbi, dei modi di dire o anche della loro più o meno dotta elaborazione in letteratura. La cultura popolare, è stata l’equipaggiamento per l’esistenza di tutti quelli che non avevano accesso alla cultura ufficiale. Ora questa radice è stata sostituita dagli scarti della cultura ufficiale, ed è finita sottoterra. E’un lavoro riconoscerla e acquisirne consapevolezza. Ad ogni modo, a scavare un poco, tutto viene dalla radice popolare, anche se magari occorre impararla dagli strumenti culturali. Fare canzoni può anche essere fare antropologia”.
In Ballate per uomini e bestie torna il concetto di capro espiatorio. L’uomo ne ha sempre avuto bisogno. Nella seconda metà del Novecento pareva che il consesso umano, Occidentale in vero, sarebbe stato in grado di superare certe logiche primordiali. Deluso?
“Non io, ma i santi protettori sì. A veder l’uomo cadere sempre negli stessi errori, nella stessa bestialità, si sono stufati e non fanno più miracoli. Oppure fanno solo miracoli al contrario, uno cammina, e poi non cammina più, per esempio. Però perdendo il miracolo è venuta meno la speranza, la gente non sa più a che santo votarsi e allora vota. Male. C’è un lavoro sulla recessione allo stato di natura. Alla legge del capobranco, la legge del più forte. O almeno di chi urla di più. Sempre di più dobbiamo lavorare sul nostro senso di responsabilità individuale”.
Ballata del carcere di Reading, contenuta in Ballate per uomini e bestie, è un omaggio a Oscar Wilde o una sua lettura particolare? Come è nata?
“Questo poema in forma di ballata, è il suo ultimo scritto. Il lascito di un Wilde molto diverso dall’esteta che ha incantato la società del suo tempo con i suoi meravigliosi e taglienti aforismi. La ballata viene dalla sua immane caduta, al fondo del quale ha scoperto la com-passione. Parte da un delitto odioso e tragicamente mai cessato: l’uccisione di una donna con il pretesto dell’amore. Ci dice in maniera spietata e lucidissima in quanti modi gli uomini uccidono ciò che amano. Ma soprattutto è una denuncia dell’oscenità della pena di morte e del carcere come strumento di non redenzione. E del tradimento del messaggio evangelico, del Cristo venuto sulla terra non per salvarci, ma per insegnarci a salvarci l’un l’altro. Wilde ha parole straordinarie per il Cristo che egli riteneva poeta e rivoluzionario: chi gli si avvicina scopre che il peccato smarrisce la bruttezza e apprende la bellezza del dolore. Tutte cose che ho cercato di mettere nella versione canzone, che pur molto riassunta, cerca di essere fedele a un testo che è un vero e proprio testamento etico, sempre attualissimo”.
“Prima si aveva una certa reticenza a dire certe cose. Adesso no”. Concetto espresso in una recente intervista. Merito o demerito del Web?
“Il web ha segnato la fine di una professione antica: il paparazzo. Ora ognuno è il paparazzo di qualcun altro, a partire da sè stessi. Ognuno è illusoriamente centro del mondo. Il web è lo straordinario strumento tecnologico che può donarci un accesso illimitato alla conoscenza e alla comunicazione. L’algoritmo però moltiplica a dismisura tutto, anche i nostri difetti. Ed è un fatto che rabbia e paura viaggino più velocemente e più efficacemente on line. E che ci sia un lavoro su questo. Sono emozioni che portano a restare connessi e reattivi, generano traffico on line. L’odio come sempre genera più profitto e le cedole si riscuotono subito. E’ una fase primitiva. E’ come se si fosse fornito a tutti una macchina molto potente senza dovere prendere la patente, senza elaborare regole, etiche e normative, a partire dai profitti e dalla tassazione di chi gestisce il sistema. Si può fare male e ci si può fare male, senza quasi rendersi conto. Dobbiamo sviluppare un’etica e regole per non finire per diffamarci tutti l’un l’altro tutto il tempo”.
Alla prossima.
Foto di copertina di Marco Zanella
INFO******
Biglietti Teatro Morlacchi: www.ticketone.it/vinicio-capossela-perugia-biglietti.html
tel. 3319488452