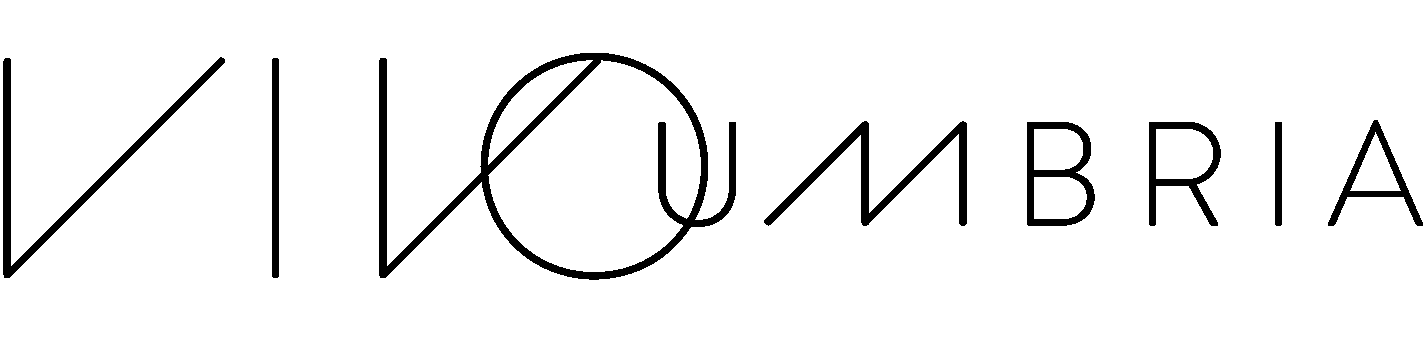PERUGIA – Avete notato i capannoni abbandonati, sempre di più, ai margini delle nostre città? Sono i resti visibili, tangibili, dell’obsolescenza tecnologica che corre, nella nostra epoca, seminando tracce evidenti del suo passato, ormai inadeguato.
Abbiamo imparato il concetto di “obsolescenza” sui nostri telefonini, che in pochi anni invecchiano e non consentono più l’accesso a funzioni e applicazioni più moderne; l’esempio attuale è Immuni, l’app di tracciamento dei contagiati Covid 19 che – al netto di ogni altra polemica – non è scaricabile su smartphone troppo vecchi. L’obsolescenza colpisce tutte le tecnologie, non solo quelle elettroniche. Ed è un problema contemporaneo per la straordinaria accelerazione scientifica, nelle tecnologie dell’informazione soprattutto, ma non si tratta di un problema nuovo. Tutti gli strumenti, tutti i prodotti, tutti i materiali e anche tutti i servizi prodotti dall’uomo, a un certo punto invecchiano e sono sostituiti da altri. L’erpice di legno tirato da uomini è stato sostituito da quello di metallo tirato da cavalli, poi da motori a scoppio. Le candele di sego da quelle di cera, pressoché scomparse con l’illuminazione a gas, poi elettrica. I dischi di vinile hanno iniziato a declinare con le musicassette e i Dvd, e ora le piattaforme di streaming hanno rivoluzione l’idea stessa di mercato discografico.
L’obsolescenza non riguarda solo i prodotti ma, ovviamente, anche i processi produttivi. Ogni oggetto che maneggiamo è costruito da macchine, ciascuna composta da innumerevoli componenti frutto dell’ingegno umano. Anche le macchine invecchiano e i processi di produzione cambiano: un esempio eclatante nella filiera di produzione di testi stampati, dalla penna alla tipografia fino a 20, 30 anni fa, oggi tutta affidata a bit e a macchine intelligenti che lavorano senza piombo.
Sembra una cosa bella, stimolante, anche epica, il manifesto futurista di Marinetti reso carne, vita, realtà.
Ma in un epoca di evoluzione tecnologica esponenziale, dove ogni lustro c’è un epocale ribaltamento dei nostri prodotti, e delle macchine che li confezionano, cosa succede agli impianti industriali divenuti obsoleti? Semplice: se possibile si ristrutturano, ovviamente; se non possibile si abbandonano. L’impossibilità può avere molteplici cause: costi eccessivi per la riconversione, prodotti e processi fuori mercato, maggiore facilità a rifare daccapo altrove (può costare molto più riconvertire impianti vecchi, anziché ricostruire con nuove soluzioni). Ed ecco che sul nostro territorio restano queste crisalidi vuote: capannoni abbandonati, a volte cadenti; magazzini lasciati alle sterpaglie; impianti che affrontano la ruggine nel silenzio di spazi anche considerevoli visitati, al più, da qualche temerario graffitaro.
Attorno a Perugia, proprio a ridosso della città, se ne possono contare decine. Causa Covid non possiamo documentare gli analoghi abbandoni di altre città, ma è evidente che non si tratta di un problema perugino.
Siamo distanti anni luce dalle botteghe artigiane tramandate di generazione in generazione, o cedute a terzi dopo attente trattative, caute nel concedere quello spazio sacro – lo spazio del lavoro – a chi poteva non meritarlo. Oggi il lavoro è desacralizzato, e se per certi aspetti è un bene, per altri è decisamente alienante.
Gli operai che potevano raccontare una vita in fabbrica, in quella fabbrica, segno anche di una identità territoriale, di una comunità, di generazioni succedute nel rapporto con quello specifico fare, e quindi essere, non ci sono più.
Restano le crisalidi vuote, ammuffite, coi resti abbandonati di macchine, sedie e tavoli, materiali edili, sporcizia. Solitamente sono recintati e si trovano nel bel mezzo di un paesaggio altrimenti continuo negli edifici ancora abitati e funzionali: casa, casa, ristorante, capannone abbandonato, fabbrica, casa, altro capannone abbandonato, casa, pompa di benzina, casa. Prima o poi qualcuno di questi corpi sfregiati verrà demolito e sostituito da qualche altro simbolo dell’impresa economica contemporanea. O forse no: crollerà prima un solaio, si piegherà qualche struttura, ci sarà uno schianto, chissà?
È straordinario pensare come questo scempio abbia un suo fascino. Un fascino morboso, forse, un po’ necrofilo. Esiste anche un tipo di fotografia specifica, chiamata Urbex (Urban Exploration), i cui adepti si intrufolano (non sempre proprio legalmente) in queste strutture al solo scopo di fotografarle. Esistono comunità Urbex anche in Italia, con bellissimi siti fotografici. Ma l’analogia con le foto post mortem in uso nella seconda metà dell’Ottocento è inevitabile. Fotografiamo il passato ormai sfuggito perché morto, o semplicemente obsoleto. Solo che i corpi di mattoni e cemento di questi impianti non troveranno mai sepoltura e diventano paesaggio.
Claudio Bezzi