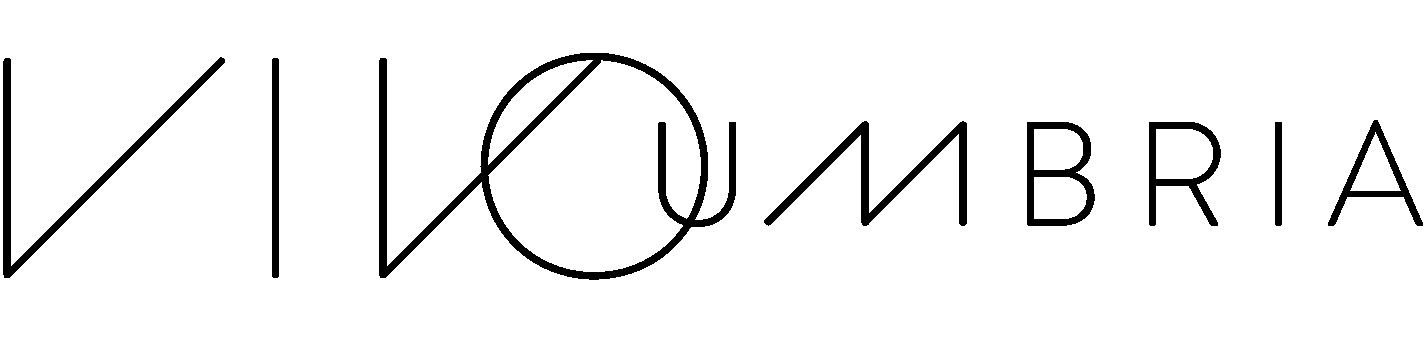PERUGIA – E’ un’antica questione che pone il problema se la cultura debba avere o meno una funzione etica. Se la sono posta nel corso dei secoli filosofi come Platone e Aristotele, poi Kant, Hegel. Nietzsche, Adorno e Benjamin, spesso con opinioni molto diverse l’uno dall’altro. Rimane il fatto che da un lato ci si appella al richiamo alla libertà culturale, in difesa del dialogo artistico anche in tempi di tensione. Dall’altro, la partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca — voluta o meno — è stata vista come una normalizzazione della presenza di figure internazionali in un contesto che molti considerano politicamente compromesso. Sul fatto si è acceso un intenso dibattito politico e culturale. Invitato a intervenire in una sessione intitolata “Leggende del cinema mondiale” e moderata dal regista russo pro-Cremlino Fëdor Bondarchuk, Allen ha manifestato il suo apprezzamento per il cinema russo, ricordando anche di aver visto Guerra e Pace di Sergej Bondarchuk in un solo giorno, Pur affermando di considerarsi un regista “apolitico” motivato soltanto, non ha escluso l’ipotesi di girare un film ambientato a Mosca o San Pietroburgo nel caso di una proposta. Questa scelta è stata però decisamente criticata, soprattutto da Kiev. Il Ministero degli Esteri ucraino ha definito la sua partecipazione una “vergogna e un insulto” al sacrificio di attori e registi ucraini vittime dei crimini di guerra russi. Il governo ha accusato Allen di “chiudere un occhio” di fronte alle atrocità perpetrate in Ucraina, sottolineando che la cultura non dovrebbe essere usata per legittimare propaganda o insabbiare crimini.
L’intervento di Woody Allen al festival di Mosca, sebbene privo di intenti dichiaratamente politici, ha inevitabilmente travalicato il piano artistico. Al centro della polemica c’è il fragile equilibrio tra arte e morale in un momento di conflitto: la partecipazione di figure globali a eventi culturali può essere vista come un segnale di apertura, ma rischia anche di essere strumentalizzata come strumento di legittimazione politica.
La relazione tra etica e arte è complessa e affascinante, perché tocca il cuore stesso della funzione dell’arte nella società. Da un lato, l’arte è spesso vista come uno spazio di libertà assoluta, in cui l’artista può esprimersi senza vincoli morali, esplorando anche temi controversi, disturbanti o provocatori. In questa prospettiva, imporre limiti etici all’arte rischierebbe di soffocare la creatività e la capacità dell’opera di interrogare il reale.
Dall’altro lato, l’arte non esiste nel vuoto: essa parla a un pubblico, riflette valori culturali e può influenzare la sensibilità collettiva. Per questo, molte tradizioni filosofiche hanno posto il problema se l’artista abbia o meno una responsabilità etica nei confronti della comunità. Un’opera può generare consapevolezza, denuncia sociale e solidarietà, ma può anche legittimare discriminazioni, violenza o pregiudizi.
In definitiva, il rapporto tra etica e arte non si riduce a una semplice contrapposizione tra libertà e limite: è piuttosto un dialogo dinamico, in cui l’arte mette in discussione i codici morali dominanti e, al tempo stesso, ne viene condizionata. Proprio in questa tensione risiede la forza vitale dell’arte, capace di provocare, educare, consolare o destabilizzare, sempre sollecitando una riflessione etica nello spettatore.